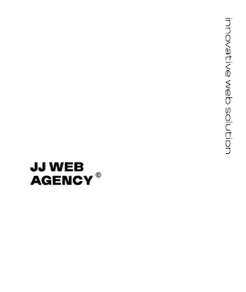La misurazione della performance ambientale è oggi una delle attività più importanti per aziende, professionisti e istituzioni che vogliono contribuire attivamente alla sostenibilità. Conoscere con precisione l’impatto di prodotti, processi e servizi sull’ambiente è infatti il primo passo per migliorare davvero le proprie strategie ambientali, rispondere alle normative e accrescere la propria competitività sul mercato. Ma come si misura la performance ambientale? Quali sono i metodi più utilizzati? E quali strumenti concreti esistono per farlo?
La performance ambientale è una misura complessiva dell’efficienza ecologica di un sistema. Non si tratta solo di verificare quante emissioni di CO₂ produce un’attività, ma anche di valutare il consumo di risorse, l’energia impiegata, i rifiuti generati, l’impatto sulla salute umana, sugli ecosistemi e sul cambiamento climatico. Per farlo in modo scientifico e comparabile, nel tempo si è sviluppata una metodologia riconosciuta a livello internazionale: l’LCA, ovvero Life Cycle Assessment.
L’LCA, o valutazione del ciclo di vita, è uno strumento metodologico che analizza l’intero ciclo di vita di un prodotto o servizio: dall’estrazione delle materie prime fino al fine vita, passando per la produzione, l’uso e il trasporto. È una metodologia “dalla culla alla tomba” perché considera tutte le fasi. L’obiettivo è fornire dati misurabili sull’impatto ambientale, in modo da poterli confrontare, migliorare e comunicare in maniera trasparente.
A regolamentare l’uso dell’LCA sono le norme ISO 14040 e ISO 14044. Questi standard internazionali descrivono il processo in quattro fasi. La prima è la definizione degli obiettivi e del campo di applicazione: bisogna stabilire perché si sta facendo l’analisi e quali limiti temporali, spaziali e funzionali si applicano. La seconda fase è l’analisi dell’inventario del ciclo di vita, chiamata anche LCI. In questo passaggio si raccolgono tutti i dati in ingresso e in uscita dal sistema analizzato: energia, acqua, materie prime, emissioni, rifiuti, prodotti finiti. La terza fase è la valutazione dell’impatto, detta LCIA, in cui si traducono i dati numerici in indicatori ambientali (per esempio potenziale di riscaldamento globale, acidificazione, uso del suolo). Infine, la quarta fase è l’interpretazione dei risultati, utile per prendere decisioni migliorative, identificare i punti critici e comunicare l’impatto ambientale in modo trasparente.
Oggi l’LCA è ampiamente utilizzata in diversi settori: dall’edilizia alla chimica, dall’agroalimentare all’automotive, fino ai servizi. È uno strumento fondamentale anche per chi si occupa di certificazioni ambientali. Tra queste, una delle più diffuse è la EPD, ovvero la Dichiarazione Ambientale di Prodotto. L’EPD è un documento standardizzato che riporta, su base volontaria, l’impatto ambientale di un prodotto o servizio secondo i principi dell’LCA. Le EPD si basano su regole specifiche di categoria chiamate PCR, Product Category Rules, che garantiscono coerenza tra prodotti simili e rendono i dati confrontabili.
Accanto all’LCA e alle EPD, esistono anche normative per la misurazione delle emissioni di gas serra, come il GHG Protocol e la norma ISO 14064. Questi strumenti sono pensati soprattutto per organizzazioni che vogliono calcolare e ridurre la propria impronta di carbonio. Insieme all’analisi ambientale dei prodotti, permettono una visione completa dell’impatto ecologico.
Oltre ai metodi, è fondamentale disporre di strumenti pratici. Per questo motivo esistono diversi software LCA, progettati per raccogliere dati, effettuare calcoli e generare report. Alcuni dei più utilizzati sono SimaPro, GaBi, OpenLCA e Umberto. Questi strumenti consentono di creare modelli di prodotto o processo, inserire dati da database riconosciuti e ottenere risultati in termini di impatti ambientali per unità funzionale. L’utilizzo di software permette di standardizzare i risultati e velocizzare le operazioni, facilitando anche l’ottenimento delle certificazioni.
Un altro aspetto cruciale è l’eco-design, noto anche come progettazione per il ciclo di vita. Si tratta di un approccio che mira a ridurre gli impatti ambientali già in fase di progettazione. L’eco-design considera fin dall’inizio la scelta dei materiali, l’efficienza energetica, la modularità, la riparabilità, la facilità di disassemblaggio e la riciclabilità. In altre parole, aiuta a progettare prodotti che siano più sostenibili lungo tutto il loro ciclo di vita, non solo durante l’uso ma anche a fine vita.
Misurare la performance ambientale significa anche definire dei KPI, ovvero indicatori chiave di prestazione. Tra i più diffusi troviamo il consumo specifico di energia per unità prodotta, le emissioni di CO₂ per prodotto finito, il tasso di riciclabilità dei materiali, l’impronta idrica, il tasso di utilizzo di materie prime seconde, o la percentuale di energia rinnovabile impiegata. I KPI permettono di monitorare nel tempo l’efficacia delle strategie adottate e di confrontare diverse opzioni progettuali o operative.
Per strutturare i KPI in modo efficace esistono vari modelli. Uno di questi è la SMART Pyramid, che organizza gli indicatori in funzione di obiettivi strategici, tattici e operativi. Un altro è il modello Results–Determinants Framework, che collega le prestazioni ambientali con i risultati economici e sociali dell’organizzazione. L’integrazione di indicatori ambientali nei sistemi di controllo di gestione è oggi una delle frontiere più promettenti della sostenibilità.
Ma perché tutto questo è rilevante anche per liberi professionisti, tecnici, consulenti e commercialisti? Perché sempre più spesso le aziende si affidano a figure esterne per mappare, analizzare e certificare la propria sostenibilità. Avere competenze in metodi come LCA, saper leggere una EPD o conoscere la norma ISO 14044 significa essere in grado di offrire un servizio tecnico qualificato, richiesto dal mercato e in linea con le direttive europee. In molti settori produttivi, la misurazione dell’impatto ambientale non è più una scelta, ma un requisito per partecipare a bandi pubblici, gare d’appalto o ottenere finanziamenti.
In questo scenario, la formazione gioca un ruolo centrale. Acquisire competenze aggiornate sugli strumenti di misurazione ambientale permette di distinguersi, di contribuire in modo attivo alla transizione ecologica e di rispondere concretamente alla domanda di sostenibilità che arriva da clienti, aziende e istituzioni.
La cultura della misurazione è alla base di ogni processo di miglioramento. Solo ciò che si misura può essere compreso, confrontato e ottimizzato. Per questo è importante che la misurazione della performance ambientale diventi parte integrante dei processi decisionali, dalla progettazione fino alla rendicontazione finale.
In conclusione, misurare la performance ambientale di prodotti, processi e servizi è una sfida complessa ma fondamentale. Attraverso metodologie come l’LCA, strumenti software, norme ISO e approcci come l’eco-design, è possibile trasformare la sostenibilità in un valore concreto, misurabile e comunicabile. I professionisti che padroneggiano questi strumenti diventano alleati strategici per le imprese, in un mondo che chiede responsabilità, trasparenza e visione a lungo termine.
Per chi desidera approfondire questi argomenti e acquisire competenze operative spendibili da subito, è possibile iscriversi al corso “Metodi e strumenti per la misurazione delle performance ambientali di prodotti, processi e servizi”, disponibile online e valido per il riconoscimento dei crediti formativi ODCEC.
È possibile iscriversi da qui.